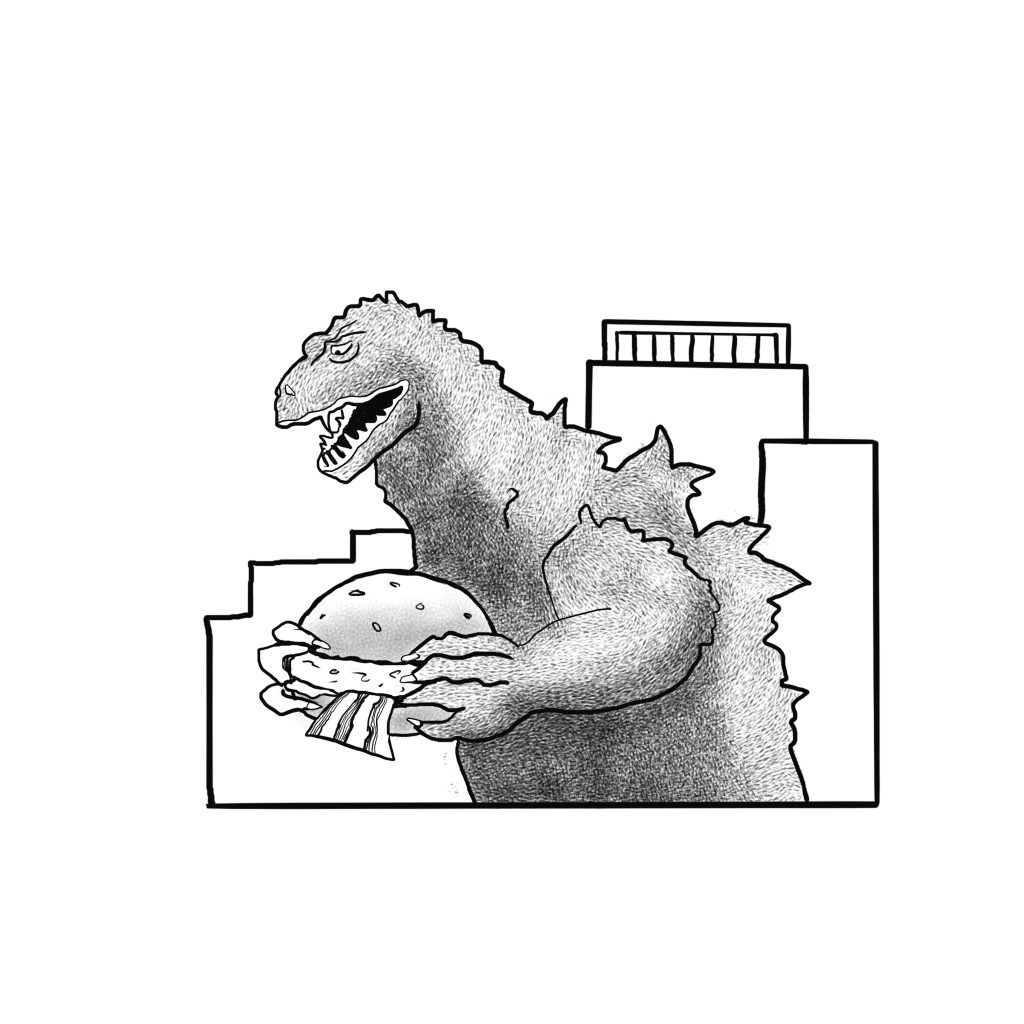Rece Rock
Avete presente l’espressione spaesata di Alberto Sordi e Anna Longhi in Le Vacanze Intelligenti mentre osservano l’opera di Gian Emilio Simonetti esposta alla Biennale di Venezia?
Ecco, io ho reagito allo stesso modo dopo aver ricevuto l’invito a una serata dedicata al sakè, la famosa bevanda giapponese, che si sarebbe tenuta in un nuovo locale chiamato Sake Boutique Izakaya. Innanzitutto, io di sakè me ne intendo quanto di meccanica quantistica. E poi alla parola boutique non vengono solitamente associati personaggi che, come me, somigliano a Bobby Elvis Munson (il panzone di Sons of Anarchy).
Ma, visto il continuo successo di questa bevanda ottenuta dalla fermentazione del riso, che a dicembre 2024 si è addirittura guadagnata un posto nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, mi sento in dovere di approfondire. Soprattutto dopo aver saputo che quasi tutti i sakè contengono il 15% di alcol, requisito minimo per soddisfare i miei personali criteri da aspirante Alcolista Anonimo.
Pare che a favorire questo suo momento di gloria abbia contribuito il nuovo modo di berlo servito freddo durante il pasto, in abbinamento alle pietanze come fosse un vino bianco. Quindi sono curioso di scoprire con quali piatti verrà accompagnata la mia sbronza.

Sake Boutique Izakaya (l’izakaya è il tipico locale nipponico) si trova nell’elegante quartiere Aventino, in piazza Albania 1, che in questo periodo è falcidiato da innumerevoli cantieri stradali e ricorda vagamente Beirut dopo i bombardamenti del 1983. Non una situazione ideale per una nuova apertura.
Dopo aver sbagliato porta e aver tentato di scardinare una finestra, entro finalmente dall’ingresso giusto. Mi accoglie calorosamente il giovane gestore, sicuramente giapponese, che esordisce con un: “Benvenuto, sono Giovanni” in un italiano perfetto che Tony Effe si sogna. Rimango un attimo perplesso ma poi penso che anche io mi chiamo Alex (all’anagrafe) e non sono certo nato nel Sussex. Si tratta di Giovanni Zhou, ideatore di questo format e uno dei soci dei tre ristoranti Sushi e Noodles.

La sala è piccolina (ci saranno in tutto una trentina di coperti) ma ben organizzata, accogliente e arredata in accurato stile moderno giapponese. O almeno credo, visto che non sono mai stato nel Paese del Sol Levante. I membri dello staff sono giovanissimi, gentili e competenti. Scopro con piacere che il bar manager è Giordano Ciccolini, già conosciuto e apprezzato per l’esperienza da Once a Centocelle, il quale propone subito un ottimo spicy spritz a base di soda al wasabi e pompelmo. Un drink buono e rinfrescante, adatto per la stagione estiva, tanto da farmi venir voglia di indossare infradito e pareo e di andare a sorseggiarlo sulla spiaggia di Yurigahama (che non è esattamente come Coccia di Morto).

Neanche il tempo di sedermi e Giovanni fa crollare una delle poche certezze che avevo prima di venire qui: il vero nome del sakè non è sakè. Un duro colpo per chi come me ancora fatica persino ad accettare la disgregazione dell’Unione Sovietica. Giovanni spiega infatti che con il termine sakè vengono indicate genericamente tutte le bevande alcoliche, mentre quello che berremo stasera si chiama nihonshu (letteralmente alcol giapponese). Inoltre, ci illustra come degustare il pasto in modo corretto, consigliandoci di prendere prima un boccone di cibo, poi bere un sorso di sakè, infine deglutire ed espirare dal naso. Non essendo certo di riuscire a farlo nella maniera giusta, ho chiesto la presenza in sala di un addetto al primo soccorso esperto della manovra di Heimlich.
La degustazione inizia con due cubetti di agedashi tofu, ovvero un tofu in tempura con salsa di dashi (un brodo leggero di pesce) e tonno essiccato (katsuobushi). Ammetto di non aver mai amato il tofu per la sua consistenza tipo spugnetta da trucco della Beauty Blender e per il suo sapore anonimo. Sarei quindi tentato di lanciare i cubetti sul tavolo come se stessi giocando a dadi al casinò municipale di San Pellegrino Terme. Per fortuna mi trattengo, perché questo tofu in tempura è sorprendentemente gustoso. In fondo, dalle mie parti si dice che “fritto è bono tutto“. Credo che questa regola valga anche a Tokyo e dintorni.

A seguire arrivano gli hanetsuki gyoza ebi, delicati ravioli di gambero alla piastra con crosta tradizionale (detta piuma o ala, che ho faticato a tagliare con le bacchette neanche fosse quella di un Boeing 747) e salsa gyoza no tare. La presentazione è coreografica e d’effetto, il ripieno del raviolo secondo me un po’ troppo asciutto.

Ad accompagnare queste prime due pietanze c’è uno degli oltre trenta sakè presenti sulla carta, un Junmai Ginjo Tatenokawa Seyriu della prefettura di Yamagata, servito fresco. Seiryu significa flusso limpido ed evoca l’immagine di un ruscello cristallino e puro. E in effetti, nonostante la sua percentuale alcolica di tutto rispetto (14%), scende piacevolmente come fosse acqua fresca bevuta in un afoso ferragosto a Matera.
Il successivo oyakodon, che letteralmente significa genitori e figli (riferito agli ingredienti principali, pollo e uova), è un piatto tradizionale da itzakaya, talmente popolare e diffuso che i giapponesi lo mangiano almeno una volta a settimana. Sopra una base di riso in bianco ci sono pollo, cipolla, uovo e tuorlo crudo. Un piatto saporito, efficace e dal gusto familiare, talmente semplice che potrebbe cucinarlo persino Paris Hilton. Forse.

Per scongiurare eventuali carenze di proteine, anche il piatto successivo è a base d’uovo. L’omurice è infatti una tipica omelette adagiata sulla solita immancabile base di riso saltato al pomodoro con mayo giapponese e salsa otafuku (preparata con decine di ingredienti impossibili da elencare e da ricordare). A essere onesto, non si tratta di una pietanza memorabile e l’aspetto ricorda un quadro di Hisao Domoto.

Il piatto forte è sicuramente l’hitsumabushi, che mi viene presentato come un vero rituale. Questa anguilla glassata di Nagoya su base di riso (chi l’avrebbe mai detto) va infatti gustata in tre fasi: prima al naturale, poi con l’aggiunta di wasabi e infine trasformata in zuppa versando il brodo caldo servito separatamente. Siccome io sono di coccio proprio come il tokkuri e gli ochoko (la caraffa e i bicchierini caratteristici), ho rischiato di versare il sakè nell’hitsumabushi e di bere alla goccia una sorsata di brodo. Fingo comunque di aver compreso le istruzioni che mi vengono date con la stessa nonchalance con cui Fantozzi finge di capire la cameriera del ristorante giapponese Sayonara per pavoneggiarsi con la signorina Silvani. D’altronde, dopo aver versato il brodo caldo nel riso, riuscire a mangiare la zuppa finale con le sole hashi ha un coefficiente di difficoltà elevatissimo, secondo solo al tordo servito alla cena della Contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare. Nonostante abbia sudato come Guillermo Vilas alla finale del Roland Garros del 1982 contro Mats Wilander (durata 4 ore e 42 minuti) per portarmi il cibo alla bocca, devo ammettere che questo piatto ha davvero qualcosa di speciale.

Il sakè che accompagna l’anguilla è un Hurzumagu Honjozo Densho (sempre del distretto di Yamagata, dove evidentemente c’è la più alta concentrazione di malati di cirrosi epatica della nazione). Stavolta, per stemperare al meglio un piatto grasso come l’anguilla, viene servito caldo. Risulta più rotondo, corposo e un pizzico più aggressivo rispetto al precedente, forse anche grazie alla sua gradazione alcolica di 15,5%.
Per mia fortuna il piatto successivo è più agevole da mangiare perché potrò finalmente usare le mani: lo spiedino di pollo e melanzane non è male e me lo gusto senza il terrore che possa sbucare dietro di me un samurai munito di katana pronto a tagliarmi l’avambraccio per non aver usato le bacchette.

I tebasaki, le alette croccanti di pollo con sale al wasabi, sono una chiusura sinceramente mesta e insipida, un po’ come gli ultimi finali di campionato della mia amata Roma. Per fortuna arriva in mio soccorso un Futsushu Kuromatsu Kenbishi, della prefettura di Hyogo, l’ultimo ottimo sakè della degustazione che aiuta a dimenticare questo piatto.

Come dessert vengono portate due palline di nama choco (cioccolato e panna non cotti) e la variante matcha, più amarognola e particolare. Ho gradito molto e, avendo ancora una fame tipo coccodrillo del Nilo, ne ho mangiate l’equivalente di un pallottoliere segnapunti di una sala biliardo. Abbinato a questo dessert, bevo uno squisito amaro creato mischiando sakè edogeshu (ovvero non diluito, 18% di gradazione alcolica), vermut e bitter al cioccolato.

È stata un’esperienza indubbiamente istruttiva e soddisfacente, sicuramente da ripetere provando altre opzioni offerte dal menu che possano venire più incontro ai miei gusti da bifolco e che mi aiutino a mantenere un peso forma da lottatore di sumo della categoria middleweight. Ma la vera diversità sta nello sperimentare gli abbinamenti tra queste pietanze e i diversi tipi di sakè offerti in questo posto. Quei sakè che, ne sono certo, nessuno chiamerà mai nihonshu.
Sake Boutique
Piazza Albania, 1
Roma
06 4555 6974